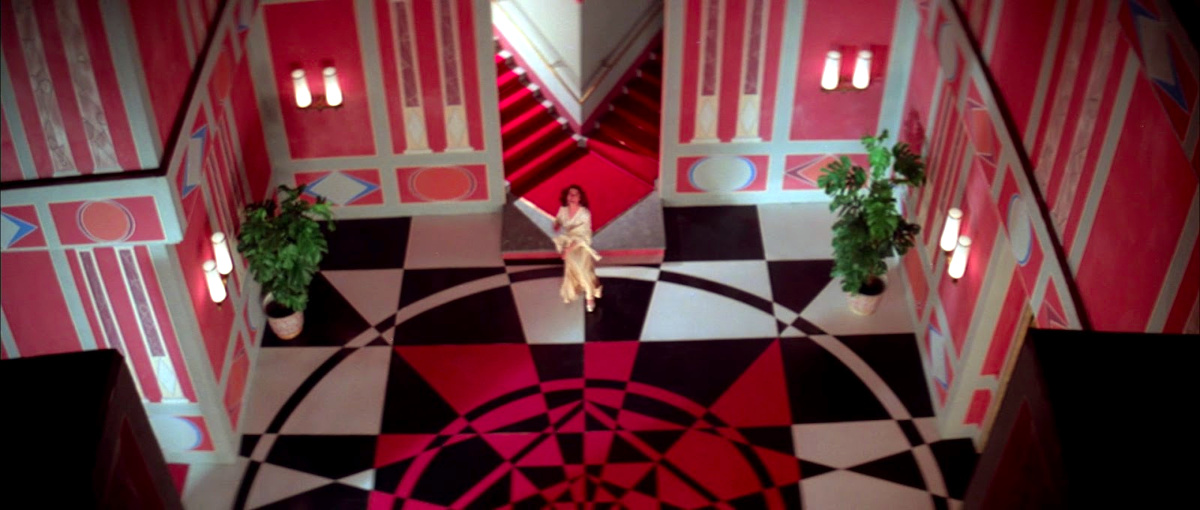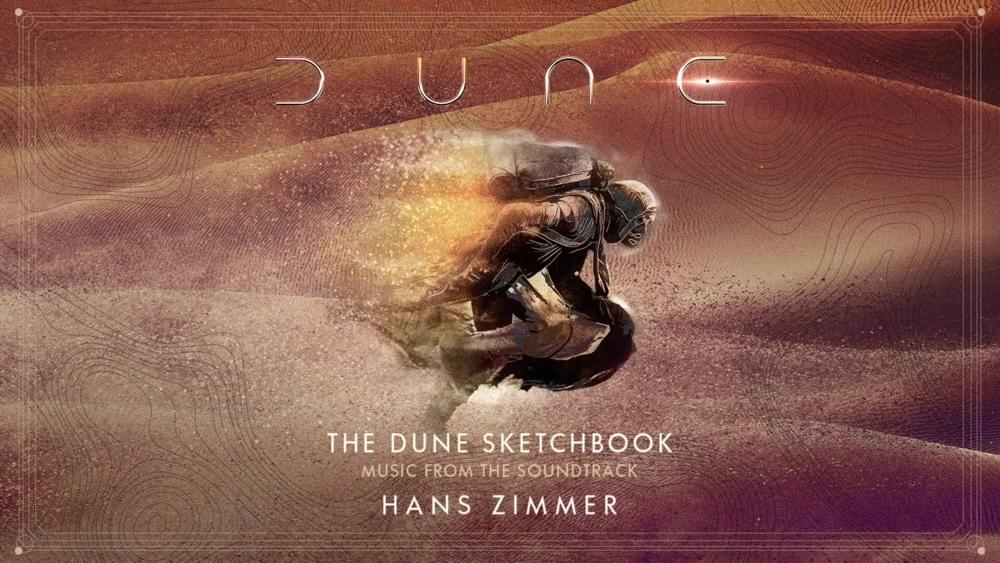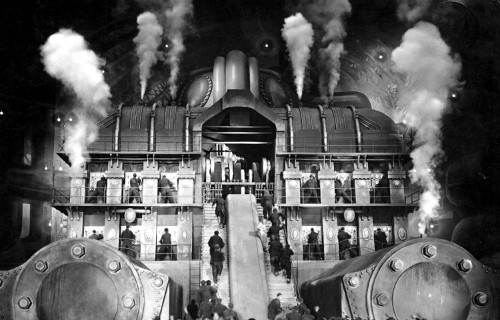Premessa: sono uno di quegli abitanti della Rete che dopo un iniziale entusiasmo per i social media, durato peraltro alcuni anni, hanno scoperto che in realtà i social gli fanno fondamentalmente schifo. Ergo, il seguente testo, pur nel tentativo di essere onesto, rilegge la realtà in questa chiave.
Negli ultimi anni i social media si sono trasformati da strumenti di connessione e scambio di idee a meccanismi sofisticati di manipolazione dell’attenzione, governati da quelli che volgarmente chiamiamo “algoritmi”, insiemi di logiche progettate per massimizzare il numero di utenti “attivi” (che di attivo hanno ben poco, se non la pure e semplice presenza e autoesposizione ai contenuti promozionali) privilegiando il contenuto più estremo e polarizzante. Quella che inizialmente sembrava una rivoluzione comunicativa si è rivelata la chiusura in una struttura altamente controllata, in cui la qualità della discussione è sacrificata sull’altare dell’engagement.
L’obiettivo primario non è più favorire un dialogo costruttivo, ma massimizzare il tempo che gli utenti trascorrono sulle piattaforme, generando interazioni che alimentano un’economia basata sulla monetizzazione dell’attenzione (e della distrazione).
Questa consapevolezza, unita ad altre considerazioni, vedi per esempio il caso di Valigia Blu, sta portando alcuni utenti (vorrei poter dire molti ma mi mancano le cifre per affermarlo) a una decisione radicale e, almeno nelle intenzioni, irreversibile: il self deplatforming, ovvero un progressivo abbandono volontario dei social per sottrarsi a un sistema che sfrutta e distorce la comunicazione pubblica, fino a spingersi in alcuni casi alla manipolazione dell’opinione a scopo politico; una scelta che non rappresenta un semplice distacco, una chiusura in una nicchia comunicativa elitaria e snob, ma diventa una forma di resistenza culturale e una riconquista della propria autonomia digitale. In un contesto in cui il dibattito viene filtrato, condizionato e spesso svilito da logiche commerciali, riprendersi il controllo sulla propria voce diventa un atto di autodeterminazione.
Abbandonare le piattaforme social non significa rinunciare alla comunicazione o all’interazione, ma piuttosto evitare ambienti digitali progettati per enfatizzare il conflitto e la superficialità. Diversi fattori rendono questa scelta non solo opportuna, ma necessaria:
- manipolazione algoritmica: i social media decidono quali contenuti privilegiare, favorendo quelli più sponsorizzati, più controversi o emozionalmente carichi per massimizzare il tempo trascorso sulle piattaforme;
- tossicità e banalizzazione del dibattito online: il brainframe di questi spazi incentiva la polarizzazione, generando dinamiche che premiano il sensazionalismo e la provocazione rispetto alla riflessione critica, creando bolle comunicative il cui unico punto di incontro è lo scontro;
- erosione della privacy e controllo sui contenuti: pubblicare su un social significa cedere il controllo sui propri contenuti, la cui visibilità dipende da scelte aziendali arbitrarie;
- sovraccarico informativo e perdita di tempo: il doomscrolling, vale a dire l’affannosa ricerca di contenuti che è in realtà un consumo compulsivo di notizie poco interessanti se non addirittura negative, è un sintomo evidente di un sistema che sfrutta la nostra ansia informativa e il nostro desiderio di una ricompensa.
Di fronte a queste problematiche, il self deplatforming emerge come una strategia per sfuggire a un ecosistema digitale sempre più distorto e ritrovare spazi più autentici di espressione e confronto.
L’idea che i social siano indispensabili per comunicare è un mito alimentato dalle stesse piattaforme più che dalle loro inconsapevoli “vittime”. In realtà, esistono molte alternative più sane e produttive che vengono sempre più sfruttate per condividere idee e costruire comunità autentiche, anche se alcune di queste possono sembrare a prima vista un’anacronistica fuga nel passato, verso le comunità virtuali tanto care a Howard Rheingold:
- blog e siti web personali: creare e gestire un proprio spazio online consente di avere il pieno controllo sui contenuti, senza essere soggetti alle logiche di un business altrui;
- newsletter: strumenti agganciati alle care, vecchie mailing list permettono di instaurare un rapporto diretto con il pubblico, senza intermediari che ne determinano la visibilità;
- forum e comunità tematiche: luoghi di discussione più ristretti e focalizzati, dove la qualità della conversazione è più importante della viralità (vedi il successo di Reddit, ma agli albori della civiltà della Rete i casi dei gruppi di Usenet o addirittura The Well);
- messaggistica privata e reti distribuite: alternative come Telegram o Mastodon offrono modelli di interazione meno invasivi e più rispettosi della privacy; curiosamente la messaggistica per alcuni è già un rifugio, per esempio per quei figli che vogliono sfuggire al controllo dei genitori, più facilmente operabile sui social.
In questo contesto, il self deplatforming non è un vero ritorno al passato, ma un’evoluzione consapevole che trova nel passato una nuova biforcazione: un modo per valorizzare nuovamente la qualità del discorso invece della quantità delle interazioni.
Scegliere di uscire dai social media è una presa di posizione chiara contro un sistema che premia la superficialità e la polarizzazione; significa riappropriarsi del proprio tempo, della propria attenzione e del proprio spazio comunicativo; non è una fuga, ma una riorganizzazione strategica della propria presenza online, per renderla più autonoma, efficace e sostenibile.
Inoltre, questa scelta ha conseguenze che vanno oltre l’individuo: se un numero crescente di utenti decide di abbandonare i social, si interrompe il flusso di attenzione che alimenta le dinamiche tossiche e si depotenzia il modello economico su cui queste piattaforme si basano (la permanenza degli utenti e la impressionante mole di dati che questi producono anche con la sola presenza). Il rischio (economico) per i social non è tanto la critica, quanto l’irrilevanza: più persone si disconnettono, meno il sistema ha valore.
Il self deplatforming non è quindi solo una scelta personale, ma un atto politico e sociale per ridefinire il rapporto con la tecnologia e l’informazione. In un’epoca in cui la comunicazione è sempre più frammentata e mediata da algoritmi opachi, tornare a controllare i propri contenuti è un atto di libertà.
Lasciare i social non significa smettere di comunicare, ma farlo in modo più consapevole, scegliendo spazi in cui la qualità della discussione conta più della quantità di interazioni. È tempo di abbandonare le piattaforme che trasformano il dibattito in un’arena infuocata di sterili conflitti artificiali e riscoprire forme di espressione più autentiche e costruttive.